Eppure corrono ancora: le canzoni di Working On A Dream
29/1/2009
Rootshighway
VOTO: 6,5
Eppure Bruce corre ancora.
Districandosi nel mezzo di una raccolta differenziata di materiale riciclato, Springsteen in fondo sta ancora seguendo le vicende dei suoi "tramps like us". Si apre riciclando un western di Sam Peckinpah questo Working On A Dream, con quel motivetto da hard rock di serie B e un'epica ritrita, ma il fuorilegge di Outlaw Pete corre per tutta la canzone, corre il cacciatore di taglie Dan per ucciderlo, corrono i violini per il finale hollywoodiano, e corre la E-Street Band per far brillare un brano che dal vivo farà crollare gli stadi. L'aveva già fatta anche My Lucky Day, girava già nei flutti del "fiume" e pure in quello che non ci era finito dentro per alimentare anni dopo le "tracce", ma evidentemente i suoi vagabondi oggi viaggiano ancora nell'"oscurità di un fiero esilio" alla ricerca del loro giorno fortunato. Era già stata fatta da mille altri anche Working On A Dream, poteva sostituirla tranquillamente con l'inno americano Star Spangled Banner, ma quel giorno da Obama lui c'era, e nella folla c'erano sicuramente anche i suoi vagabondi, con tutti questi sentimenti ingenui e retorici necessari all'occasione. L'aveva già fatto Roy Bittan il giro di piano che apre Queen Of The Supermarket, forse passeggiando al limite della città, ma quello che ci trovano lì i suoi vagabondi oggi non è più l'oscurità delle proprie paure, ma scintillanti e luminosissimi centri commerciali aperti alla domenica. Può da solo Springsteen oggi "soffiarli lontano da questo fottuto posto", quando è nella seconda corsia che essi trovano vita e amore, non certo nel nulla delle loro case e dei loro 57 canali televisivi con dentro niente? E allora Bruce li segue, a costo di venire risucchiato nel loro nuovo amore pacchiano di This Life, nella romanza passionale televisiva di Kingdom Of Days, nella evanescente delicatezza di Tomorrow Never Knows o nelle straripate acque blues di una Good Eye riciclata già due volte da un palco di un tour solitario e dalle notti di Halloween del diavolo del New Jersey. In Life Itself e What Love Can Do i suoi vagabondi stanno solo ricercando le sensazioni abbandonate in un vecchio tunnel dell'amore, in Surprise Surprise ottimizzano il poco tempo concesso dalla vita odierna cercando solo emozioni veloci, come l'attimo che ci vuole a memorizzare il brano più pop della sua carriera. E Bruce gli concede tutto il pop di cui hanno bisogno, senza timore di perdere dignità o credibilità, con encomiabile coraggio. Perché lui sa che i suoi vagabondi prima o poi si fermeranno, come si sono fermati i loro amici, i Bobby Jean d'un tempo, i Terry di ieri o i Danny della Last Carnival di oggi. E lui sarà pronto ad immortalarli in un nuovo film, fornendo mille altre The Wrestler per commentare le immagini, con quella splendida poetica secca e tesa che gli viene chissà perché solo quando è davanti ad uno schermo. Vale a dire quando ricicla ancora una volta una Streets Of Philadelphia, una Missing, una Dead Man Walking…(Nicola Gervasini)
venerdì 30 gennaio 2009
mercoledì 28 gennaio 2009
WHITLEY - The Submarine

Buscadero
Gennaio 209
VOTO: 7
Ha 23 anni e viene da Melbourne Lawrence Greenwood, in arte Whitley, e il suo disco d’esordio The Submarine arriva in distribuzione sulla nostra penisola ad ormai un anno di distanza dalla sua pubblicazione. Poco male, meglio tardi che mai direbbe qualcuno, e soprattutto ben venga recuperare qualche puntata persa del fervente mondo australiano se serve ad aggiungere un altro nome importante all’ormai lunga lista di nuovi folk-singer alla Nick Drake. O probabilmente ormai, per non tirare sempre in ballo lo spirito del povero Nick, dovremmo forse parlare di seguaci di un palato predisposto alle tinte opache di un certo folk alternativo moderno, un mondo che ha in Neal Halstead dei Mojave 3 o in Bonnie Prince Billy degli ormai riconosciuti padri, in Josh Ritter il più meritevole degli adepti e in Bon Iver l’ultimo arrivato. Chi più ne ha ne metta insomma, e in questo caso un rimando stilistico preciso ce lo suggerisce lo stesso Whitley, interpretando in bella e tesa versione la splendida Mojo Pin di Jeff Buckley, raro caso di cover registrata senza troppi riguardi e genuflessioni nei confronti dell’autore. Ma già prima di arrivare alla chicca del disco eravamo passati attraverso le oblique partiture di una Cheap Clothes che si adagia tra un triste violino e il dobro del produttore Nick Huggins, e una Lost In Time che piazza subito il colpo decisivo con la sua melodia minacciosamente lieve. Whitley è giovane e alle prime armi, ma sembra maneggiare già bene l’arte di far convivere un songwriting elaborato con una certa ricerca musicale, come dimostra sicuramente il variegato arrangiamento di A Shot In The Stars, che interseca mille voci e tastiere, o una I Remember che invece si gioca tutto su un dialogo tra piano e chitarra acustica. Non sempre trova la miscela giusta magari: la stessa The Submarine sembra presagire qualcosa che non accade mai, tra sospiri, loops e sintetizzatori, chitarre e violini, tanto carburante per un motore che alla fine non parte con la dovuta potenza. Paradossalmente un difetto tipico della troppa sicurezza nei propri mezzi, quando invece sarebbe stato meglio cercare qualche spunto in più con più modestia, e soprattutto nei testi, che colgono bene le immagini evocate dalla musica, ma non riescono a risultare determinanti. Anche perché The Submarine, nonostante la sua impostazione decisamente sperimentale e la sua ricercata originalità, sta ancora dalla parte dei dischi che seguono uno stile invece di trainarlo. E ancor più paradossale è il fatto che è proprio quando si spoglia completamente di mille orpelli da sala registrazione, come nella semplice More Than Life, che Whitley dimostra di poter essere prima di tutto un autore da seguire. E ancor più nell’ottima All Is Whole, dove riaffiora nuovamente lo spirito di Buckley Jr. con il suo cimiteriale coro finale, rappresenta il momento in cui chiedi al mondo di far silenzio per poter cogliere ogni attimo e ogni sfumatura della canzone, prima che The Life I Keep mandi tutti a nanna dopo solo 31 minuti di sogni e una certa sensazione che non tutto quello che si poteva dire è stato detto. Il secondo disco dovrebbe essere già in cantiere, mentre The Submarine quest’anno ha mietuto qualche consenso di critica ma ancora troppa poca distribuzione, e il ragazzo passerà i primi mesi del 2009 a girare gli Stati Uniti in malinconico tour acustico solitario. Una vecchia storia di destini da losers che ci piace sempre raccontare (chissà perché poi…), e ci consola pure sapere che ci sono ancora giovani con la voglia di viverla così intensamente.
(Nicola Gervasini)
(Nicola Gervasini)
sabato 24 gennaio 2009
ROSE KEMP - Unholy Majesty

Rootshighway
14/01/2009
VOTO: 6,5
Se vi siete esaltati quest'anno per il folk-metal dei Black Mountain, siete pronti anche per apprezzare Unholy Majesty, terzo disco di Rose Kemp. La ragazza viene da Bristol, il folk ce l'ha nel sangue da sempre visto che è la figlia di Maddy Pryor e Rick Kemp, rispettivamente voce e basso degli Steeleye Span. Proprio gli orgogliosi genitori hanno tentato di instradare la pargoletta sulle orme di famiglia quasi costringendola a registrare un disco d'esordio (Glance del 2003) in veste da pura folk-singer, disco che lei ha quasi rinnegato. Vogliosa invece di concedere le proprie grazie vocali al mondo della musica alternativa, Rose si è immersa in una serie di esperimenti di avanguardia che l'hanno vista spesso esibirsi in solitudine con show fatti solo di vocalizzi in loop. Unholy Majesty segue di un anno il suo esordio da nuova sacerdotessa del metallo di Bristol (A Hand Full Of Hurricanes), ed è un interessante pot-pourrì di folk stralunato alla Joanna Newsom (si senta la pianistica Flawless a riguardo), enfatici recital da oscura signora alla Diamanda Galas, classicismi da progressive inglese uniti a sferragliate da doom-metal anni 90. Il paragone fatto all'inizio con i Black Mountain resta forse il più vicino alla realtà, visto che la Kemp ha lo stesso gusto di alternare all'interno dello stesso brano momenti onirici a esplosioni di rabbia, e lo stesso vezzo di impiantare elementi di disturbo noise-core (i sintetizzatori che sovrastano gli archi in Nature's Hymn), lasciandosi andare anche alla "normalità" della psichedelica Wholeness Sounds. L'arma vincente che rende Unholy Majesty esportabile anche per palati più classici è una band ben assortita che unisce le chitarre pesantissime di Joe Garcia, il violino non sempre suadente di Sue Lord e soprattutto il mix di synth e organo hammond di Dan Greensmith. Un intreccio di strumenti affascinante, che raggiunge il suo apice nella conclusiva title-track, che inizia con un testo decisamente sinistro e si lascia andare ad una lunga coda strumentale che racchiude tutto, folk inglese, metallo british e l'uso di toni maestosi e apocalittici tipici dell'epic-metal. In questo senso anche l'iniziale Dirt Glow è abbastanza rappresentativa di questa nuova via stilistica della musica inglese: inizia su toni eterei e esplode a metà canzoni in un quasi rap-metal alla Rage Against The Machine, mentre Nanny's World utilizza lo stile delle ninna nanne per promuovere nuovi incubi da film horror. Siete dunque avvertiti, Unholy Majesty è un disco pesante (in tutti i sensi possibili), realizzato con suoni puliti e lontani da qualsivoglia ruralità da Chris Sheldon, solitamente mixerista di genere (spesso nella squadra di tecnici di Therapy?, Foo Fighters e Anthrax, e da qui forse il suono molto anni '90 delle chitarre più hard), ma, se avete voglia di ascoltarlo con attenzione, nasconde un'artista con buona personalità e discreta penna di genere, che potrebbe anche maturare ulteriormente nel corso della sua carriera. (Nicola Gervasini)
martedì 20 gennaio 2009
NIBS VAN DER SPUY - A Bird in the Hand
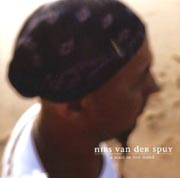
09/01/2009
Rootshighway
VOTO: 7
Difficile dire quanto il cosmopolitismo musicale vagheggiato dalla cosiddetta "world music" degli anni '80 sia davvero riuscito ad abbattere le barriere culturali, così come prevedeva in tempi ancora non sospetti Peter Gabriel, colui che di questa ideologia terzomondista è stato promotore e uno dei principali fautori occidentali. Oggi la musica sembra essersi rinchiusa in nicchie specialistiche, con atteggiamenti ben lontani dalle larghe vedute antropologiche auspicate vent'anni fa, tanto che la stessa espressione "world music" è quasi caduta in disuso. Sicuramente negli anni i ritmi e i sapori di culture lontane hanno portato nuove idee e linfa vitale a quel vecchio dinosauro stanco che è il rock, ma dall'incontro tra musica africana e canzone occidentale, giusto per fare un esempio, probabilmente non è mai nata una nuova era musicale come sperava l'ex Genesis, quanto solo un reciproco e proficuo scambio di suoni. Sono album come A Bird In The Hand di Nibs Van Der Spuy a dimostrare che comunque l'errore è stato forse il mirare troppo in alto, perché senza pensar di far troppe rivoluzioni, può accadere che in Sud Africa un bianco di evidenti origini olandesi stia portando avanti un interessantissimo discorso che unisce il folk, il soft-core indipendente tanto in voga di questi tempi e temi e ambientazioni africane. Voce soffusa molto simile a quella di Neal Halstead dei Mojave 3, una grande perizia tecnica con la chitarra acustica (usa spesso una chitarra portoricana a quattro corde), che ricorda molto certi virtuosismi di Bruce Cockburn (ascoltate gli strumentali Brunette On A Bicycle e Under A Tongaat Moon), e un amore per testi evocativi e pieni di immagini da cartolina. D'altra parte quando un disco inizia con un verso come "c'è una casa abbandonata su una pianura del Mozambico, da una porta rotta entra una pioggia perpetua…" è impossibile non venir subito catapultati in altri mondi con l'immaginazione. Indeciso tra il seguire fedelmente vecchi schemi europei (May You Shine esagera nel cercare Nick Drake), nell'ostentare frequentazioni caratterizzanti (il bel duetto con l'amico Piers Faccini nella quasi programmatica Shaded In Blue) o nel cercare sapori caraibici (il divertente reggae di Cry For You, che assomiglia parecchio a Wonderin' Where The Lions Are di Cockburn), Van Der Spuy è un artista che ricorda per spirito Archie Roach, il cantautore australiano che negli anni '90 riuscì a coniugare perfettamente folk americano con tradizioni lontane (in quel caso quelle dei aborigeni). Il difetto di A Bird In The Hand è forse di essere un album ancora troppo occidentale, troppo allineato a schemi che la scena indipendente degli ultimi dieci anni sta usando e abusando, quando forse un po' più di coraggio nel respirare l'aria di Durban avrebbe portato più originalità. Resta comunque la scoperta di un buon autore al quale val la pena dare una chance per apprezzare bei brani autunnali come With Every Step, Searching For The Rainbow o la delicata Flower In The Rain. (Nicola Gervasini)
mercoledì 14 gennaio 2009
TRACY CHAPMAN - Our Bright Future TONI CHILDS - Keep The Faith
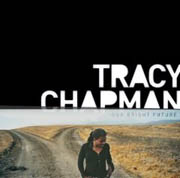
Rootshighway 7/1/2009
Tracy Chapman : 6,5
Toni Childs: 7,5
E' un evidente azzardo accomunare l'arte di Toni Childs e Tracy Chapman, suona più o meno come tentar di far andare d'accordo diavolo e acqua santa, ma ancora oggi nella nostra mente i loro nomi rievocano quella fantastica "women's wave" del 1988 che riportò concetti come poesia, songwriting e folk anche nella musica più mainstream. Suzanne Vega fu la prima e la capostipite, la Chapman rappresentò il caso commerciale più clamoroso, e con loro vennero una serie di artiste (Edie Brickell, Indigo Girls, Michelle Shocked, per citare quelle che ancora oggi transitano sulle nostre pagine) che riscrissero il modo di parlare al femminile nella canzone d'autore, e ancora oggi la loro influenza e importanza risulta palese. Così come pare però evidente che i loro percorsi artistici si siano alquanto persi tra produzioni indipendenti senza valenza storica ed un comprensibile calo d'ispirazione.In questa diaspora Tracy Chapman è stata forse la più regolare nel pubblicare, ma l'ha fatto senza mai più confermare né lo spessore, né il successo del suo mitico esordio, neppure quando ha affidato le sue canzoni a produttori à la page (John Parish nobilitò i suoni di Let It Rain del 2002). Our Bright Future è il suo ottavo disco ed è già stato salutato come un ritorno al folk e ad una dimensione da roots-music che a dire il vero Tracy non aveva mai abbandonato. Al massimo, senza scomodare l'irripetibile esordio, queste undici canzoni sembrano riprendere un discorso iniziato ai tempi di Crossroads (1989) e subito abbandonato per gli scarsi riscontri in termini di gradimento: una via cantautoriale leggera e riflessiva, sempre basata su un continuo dialogo tra chitarre acustiche ed elettriche e tra piano e organo, intrecci che l'espertissimo produttore Larry Klein si assicura di tenere sempre in pieno torpore da soft-folk da salotto. La differenza rispetto alle sue ultime produzioni è invero poco percettibile, i temi sono sempre quelli di una ragazzina che sogna un mondo migliore (Something To See) fatto di affetti (A Theory) e non di guerre (Our Bright Future). Tracy gigioneggia con la sua voce sulle sue tipiche nenie, a volte cogliendo la melodia giusta (Save Us All è davvero notevole), a volte addormentandosi un po' sul pentagramma (Thinking Of You), ma se è indubbio che brani come Conditional o anche il contagioso singolo Sing For You rappresentano tasselli importanti del suo percorso, appare anche evidente che Our Bright Future confermi nella buona sorte i suoi limiti, quelli di una cantautrice alla quale probabilmente è stato chiesto troppo senza avere una spina dorsale adatta a reggere il peso di grandi responsabilità artistiche.
 Altra storia invece quella di Toni Childs, probabilmente la più talentuosa dell'ondata, e sicuramente quella con la voce più particolare. La ragazza ai tempi ha bruciato la propria carriera in tre dischi che evidenziavano un savoir faire compositivo e interpretativo oltre la media, ma che furono purtroppo lasciati in mano ai produttori sbagliati. Il pluridecorato Union (1988) era confezionato con un gusto ancora troppo immerso negli anni '80, il coinvolgente House of Hope (1991) era sovra-arrangiato dall'ex fidanzato David Ricketts (che qui torna in cabina di regia, fortunatamente recuperando il senso della misura dimostrato ai tempi di May Day di Matthew Ryan), mentre sull'ambizioso e stravolgente Woman's Boat (1994) pesava l'ingombrante influenza di Peter Gabriel (il disco era co-prodotto dal suo ingegnere di fiducia David Bottrill negli studi della Real World) e Robert Fripp. Fatta eccezione per alcuni inediti per una raccolta del 1996, da allora della Childs si erano perse le tracce, smarrita nei suoi peregrinaggi di donna disturbata da un'infanzia che a raccontarla sarebbe necessario un libro, e dalla lotta contro il suo ipertiroidismo. Keep The Faith è il suo quarto disco, vorremmo definirlo atteso, se non fosse che il suo nome era caduto inevitabilmente nel dimenticatoio. Ritrovare la voce di Toni ancora in più che splendida forma è un piacere, ancor più scoprire che 15 anni di silenzio sono valsi un disco finalmente prodotto con i suoni giusti, un main-rock dalle tinte soul a volte anche un po' grossolano, ma suonato senza esagerazioni e senza cercare colpi ad effetto. Keep The Faith in questo senso rappresenta il matrimonio finalmente riuscito tra la verve istrionica della Childs e un lavoro in studio che la tiene ancorata a terra. Il funky-rock di Revolution, la tensione elettrica della strabiliante I Saw God In A Supermarket, la soul-ballad tutto fiati di Blind o la quasi caraibica Mama's In The Kitchen ci restituiscono una penna che ha assunto tinte decisamente black. E anche la title-track, Heart That Matters e When All Is Said And Done la confermano come interprete dotata di rara comunicatività. A voler trovare il pelo nell'uovo, oltre alla mancanza di quello struggimento d'artista d'un tempo, che faceva male a lei, ma bene all'originalità delle sue composizioni, resta anche negli arrangiamenti un gusto di fondo classico, per non dire sorpassato, che forse non le permetterà di comunicare come potrebbe con le nuove generazioni di ascoltatori. Comunque vada, bentornata Toni…(Nicola Gervasini)
Altra storia invece quella di Toni Childs, probabilmente la più talentuosa dell'ondata, e sicuramente quella con la voce più particolare. La ragazza ai tempi ha bruciato la propria carriera in tre dischi che evidenziavano un savoir faire compositivo e interpretativo oltre la media, ma che furono purtroppo lasciati in mano ai produttori sbagliati. Il pluridecorato Union (1988) era confezionato con un gusto ancora troppo immerso negli anni '80, il coinvolgente House of Hope (1991) era sovra-arrangiato dall'ex fidanzato David Ricketts (che qui torna in cabina di regia, fortunatamente recuperando il senso della misura dimostrato ai tempi di May Day di Matthew Ryan), mentre sull'ambizioso e stravolgente Woman's Boat (1994) pesava l'ingombrante influenza di Peter Gabriel (il disco era co-prodotto dal suo ingegnere di fiducia David Bottrill negli studi della Real World) e Robert Fripp. Fatta eccezione per alcuni inediti per una raccolta del 1996, da allora della Childs si erano perse le tracce, smarrita nei suoi peregrinaggi di donna disturbata da un'infanzia che a raccontarla sarebbe necessario un libro, e dalla lotta contro il suo ipertiroidismo. Keep The Faith è il suo quarto disco, vorremmo definirlo atteso, se non fosse che il suo nome era caduto inevitabilmente nel dimenticatoio. Ritrovare la voce di Toni ancora in più che splendida forma è un piacere, ancor più scoprire che 15 anni di silenzio sono valsi un disco finalmente prodotto con i suoni giusti, un main-rock dalle tinte soul a volte anche un po' grossolano, ma suonato senza esagerazioni e senza cercare colpi ad effetto. Keep The Faith in questo senso rappresenta il matrimonio finalmente riuscito tra la verve istrionica della Childs e un lavoro in studio che la tiene ancorata a terra. Il funky-rock di Revolution, la tensione elettrica della strabiliante I Saw God In A Supermarket, la soul-ballad tutto fiati di Blind o la quasi caraibica Mama's In The Kitchen ci restituiscono una penna che ha assunto tinte decisamente black. E anche la title-track, Heart That Matters e When All Is Said And Done la confermano come interprete dotata di rara comunicatività. A voler trovare il pelo nell'uovo, oltre alla mancanza di quello struggimento d'artista d'un tempo, che faceva male a lei, ma bene all'originalità delle sue composizioni, resta anche negli arrangiamenti un gusto di fondo classico, per non dire sorpassato, che forse non le permetterà di comunicare come potrebbe con le nuove generazioni di ascoltatori. Comunque vada, bentornata Toni…(Nicola Gervasini)giovedì 8 gennaio 2009
SHELLEYAN ORPHAN - We Have Everything We Need

22/12/2008
Rootshighway
VOTO. 7,5
Secondo la teoria che la storia rende giustizia ai perdenti solo in lungo periodo, in questo ultimo decennio stiamo assistendo ad una continua riesumazione e doverosa riscoperta di un mondo musicale degli anni '80 che definire "underground" sembra quasi di ingigantirne la portata di notorietà acquisita. Chissà quanta fatica in meno avremmo fatto per capire da dove arrivano tante belle idee assimilabili al brit-folk più classico sentite in queste anni, se solo oggi fosse stato possibile scoprire l'opera decisamente all'avanguardia di gruppi come i Shelleyan Orphan. Probabilmente il loro nome se lo ricordano bene i fans dei Cure, perché all'orecchio fino di Robert Smith non sfuggì la genialità e la fabbrica di nuovo contenuta nel loro esordio Helleborine del 1987, da lui tanto apprezzato da portarseli in giro per aprire il tour di Disintegration nel 1989. Formati dal duo Caroline Crawley e Jem Tayle, gli Shelleyan Orphan pubblicarono ancora due album (Century Flower del 1989 e Humroot del 1992), prima di sciogliersi e restare un mito per pochi. We Have Everything We Need, il loro quarto album corredato con copertina shakespeariana, arriva a distanza di sedici anni per riprendersi il maltolto e riproporre lo stesso mix di tradizioni folk, orchestrazioni a metà tra il miglior Robert Kirby (il leggendario arrangiatore di Nick Drake) e musica barocca, e un approccio compositivo figlio della dark-era degli anni '80 (nella prima formazione della band militava anche il fratello di Kate Bush, giusto per rimanere nell'ambito). C'è tantissimo della musica sentita in questi anni in questo cd, da Joanna Newsom al freak-folk statunitense, e anche qualcosa di più, a giudicare dall'originale bossa-nova britannica dell'iniziale Bodysighs. La perfetta melodiosità elettro-acustica dell'emozionante How a Seed Is Sown, la ieratica religiosità della tesissima Judas, la leggerezza quasi country di Something Pulled Me: sono queste le canzoni che aprono il disco, e sembra quasi che il gruppo abbia voluto sparare subito le cartucce migliori per paura di non sembrare più all'altezza dei loro golden years. In tutte, grande evidenza ha la voce di Caroline, mentre la voce tipicamente british di Jem fa capolino nella lisergica Evolute, quasi una scampagnata dei Velvet Underground nelle green hills inglesi. Se l'evocativa Host riporta in auge sperimentalismi psichedelici d'un tempo, Your Shoes ritorna ad un folk-pop orecchiabile e decorato con una sezione d'archi decisamente à la Cure (stesso sound di fondo della loro Lullabye per intenderci). La seconda parte del cd offre meno sorprese: gli impasti vocali di I'm Glad You Didn't Jump Out Of The Car That Day o il malinconico dialogo tra orchestra e pianoforte di I May Never e Beamheart ammaliano, ma non catturano. Buono nel finale il duetto tutto scariche elettriche loureediane di Bosom, a riprova di una creatività ecletticamente disordinata che è stato davvero un peccato aver perso per così tanto tempo. Bentornati. (Nicola Gervasini)
Iscriviti a:
Post (Atom)
BILL RYDER-JONES
Bill Ryder-Jones Lechyd Da (Domino 2024) File Under: Welsh Sound I Coral sono da più di vent’anni una di quelle band che tutti...
-
12/12/2006 Rootshighway VOTO: 6 Accade di trovarsi davanti ad opere che hanno un doppio valore, uno storico e, potremmo dire, "filologi...
-
NICOLA GERVASINI NUOVO LIBRO...MUSICAL 80 UN NOIR A SUON DI MUSICA E FILM DEGLI ANNI 80 SCOPRI TUTTO SU https://ngervasini.wixsite.com...

